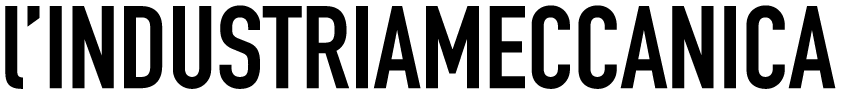Trattati internazionali: strumento del passato o nuovo futuro?
Il Ttip è naufragato. Ecco perché.
13 mar 2017
Alessandro Durante

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 707
Di Ttip, letteralmente Transatlantic Trade Investment Partpership, tra Unione europea e Stati Uniti, se ne è parlato molto in questi ultimi tre anni, forse un po' troppo e probabilmente un po' a sproposito. Se a questo aggiungiamo un pizzico di strumentalizzazione politica fine a se stessa, ingrediente che non manca mai neanche nei periodi di peggiore carestia, il gioco è fatto. Un trattato internazionale di grandissima rilevanza per il commercio europeo viene affossato senza pietà. Apparentemente. In realtà le cose stanno in modo un po' diverso, ma sempre centrale è il ruolo e, soprattutto, la potenza della comunicazione digitale che i social media consentono a ognuno di noi. Il Ttip è stato innanzitutto vittima di se stesso e di chi lo ha strenuamente promosso. Anzitempo. Il primo elemento da considerare è proprio il "fattore tempo". Avete presente quanto tempo occorre per stilare un qualunque contratto tra due parti che vogliono acquistare o vendere un bene? Pensate a quante volte avete dovuto leggere, correggere, rivedere, discutere il contratto di acquisto della vostra casa. Almeno un mese. Ipotizziamo che il valore del bene sia stato di 250mila euro e che siamo di fronte a due controparti che effettivamente vogliono l'una vendere e l'altra acquistare il bene oggetto del contratto. Ora, sostituiamo le due controparti con le macchine istituzionali, amministrative, legali e commerciali di due federazioni di stati come gli Usa (50 Stati) e la Ue (28 Stati), aggiungiamo il fatto che nessuno dei due ha ancora ben definito al proprio interno cosa "vendere" e cosa "accettare" e infine che il valore del contratto oscilla in un incremento del Pil della Ue tra i 70 e i 120 miliardi di euro e di un incremento di 50-100 miliardi di euro per gli Usa. Fatta questa premessa risulta evidente che per un'operazione di questo tipo il tempo necessario alla sua finalizzazione non possa essere inferiore ai 10-15 anni, se le macchine burocratiche Ue e Usa funzioneranno alla perfezione. 
Cosa rende complicato un accordo come il Ttip?
Principalmente da parte degli Usa la contrarietà nei confronti di un accordo "mediano" su ogni punto che avrebbe portato a modifiche, e quindi costi, su ogni aspetto del trattato, mentre la Ue non è stata in grado di parlare con una voce sola. Riguardo a quest'ultimo aspetto il caso Ttip, così come sta accadendo per Ceta, l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada, ha il pregio di aver fatto fare a tutti noi una seria riflessione sul modello e sull'affermazione dell'uso in politica internazionale dei social media. Questo fenomeno, che potremmo chiamare della "discussione diffusa", è ormai abitualmente usato anche dai personaggi politici, da qualche anno a questa parte, su qualunque tavolo di confronto e a qualunque livello contribuendo ad aumentare il grado di incertezza nelle decisioni. È probabilmente giunto il momento di ricondurre i cittadini europei allo strumento della delega. Riportare la fiducia nei decisori politici, attraverso l'esercizio del voto, deve essere il primo obiettivo di tutti i paesi per poter tornare a governare la politica, soprattutto internazionale.
Perché è importante il Ttip? Luci e ombre della Trump-onomics
Sin dalla fine della seconda guerra mondiale il rapporto, politico soprattutto, con gli Stati Uniti è risultato centrale per l'Europa. Ancora di più lo è stato negli anni post crisi che hanno visto gli Usa guidare la ripresa mondiale, soprattutto grazie a consumi interni dinamici e robusti. Oggi la Trump-onomics, come la definiscono gli americani e per quanto la possiamo ipotizzare oggi, presenta opportunità e rischi in egual misura. «Dai discorsi fatti in campagna elettorale ci possiamo aspettare una politica fiscale fortemente espansiva caratterizzata da aumento di spesa pubblica e sgravi fiscali a famiglie e imprese» afferma Alessandra Lanza head of industrial and regional sales di Prometeia «creando una situazione sicuramente favorevole per chi esporta beni e tecnologie ad alto valore aggiunto come l'Italia». Allo stesso tempo i rischi dell'America First, annunciato ancora nella fase di passaggio di consegne con l'amministrazione Obama, non sono pochi e assai rilevanti come sottolinea ancora Alessandra Lanza. «È facile immaginare un aumento del deficit pubblico, già molto alto, unito a un importante deficit commerciale. Due deficit gemelli che, se affiancati all'annunciata deregulation dei mercati finanziari, a misure fortemente protezionistiche, a una protratta volatilità dei mercati valutari e al rialzo dei rendimenti nei confronti dei paesi emergenti, rappresentano la base perfetta per nuove bolle speculative». La politica "Trumpiana" rappresenta per l'elettore medio Usa una via d'uscita per limitare gli aspetti negativi della globalizzazione che le famiglie subiscono. Non è detto che la stessa ricetta sia applicabile, in tutto e per tutto, alle imprese americane. Soprattutto quando vediamo che il 23% delle importazioni dal Messico nel 2014 è fatto da aziende statunitensi ed è pari a più di 92 miliardi di dollari. È certamente vero che questa cifra rappresenta meno dell'1% del Pil degli Usa ma di questi tempi saranno veramente disposti a costruire un muro e a rinunciarvi?
Energia, Edilizia, Alimentare, Movimentazione e logistica, Sicurezza e ambiente, Industria varia, Industria, TTIP